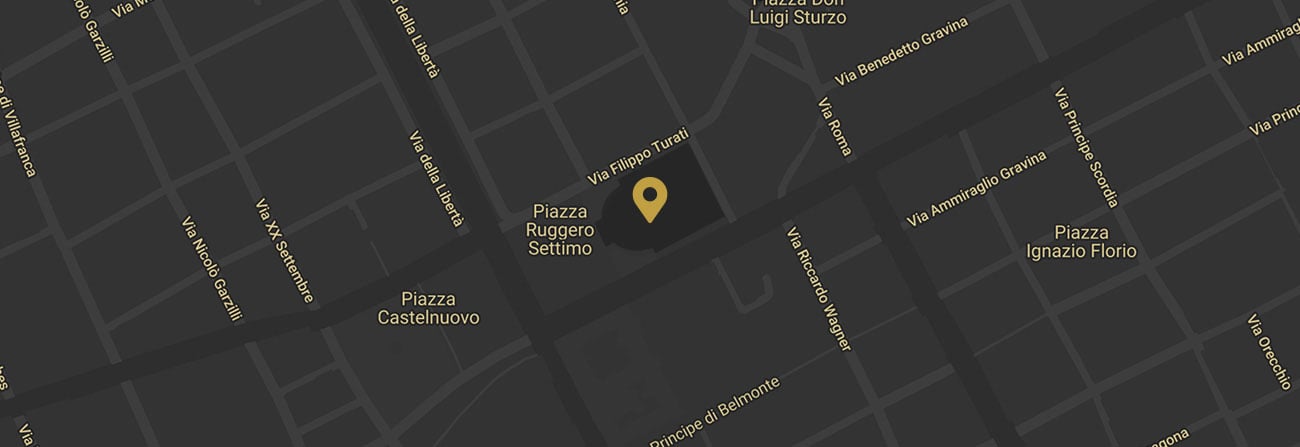Piraino/Chopin /Beethoven
GÜNTER NEUHOLD direttore
NELSON GOERNER pianoforte
-
Luogo
-
Politeama Garibaldi - Palermo
-
Giorno
ora
Durata
Prezzo
-
Giorno
Sabato 06 Dicembre 2025
Ore
17,30
Durata
90min.
Prezzi
30 - 18 €
-
Programma
-
Simone Piraino
Palermo 1985Canto notturno (prima esecuzione assoluta - nuova commissione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana)
Composto su commissione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, Canto notturno, che sarà presentato in quest’occasione in prima esecuzione assoluta dall’orchestra del capoluogo siciliano, è uno dei lavori più recenti di Simone Piraino, compositore, musicologo e manager dello spettacolo palermitano, che ha compiuto i suoi studi all’Università di Palermo, dove ha conseguito le lauree in Discipline della Musica (2007) e in Musicologia (2010), e al Conservatorio di Palermo, dove, oltre ad aver ottenuto il master in Organizzazione e management dello spettacolo (2012), si è diplomato in Composizione. Docente di ruolo al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, Istituzione della quale oggi è anche Vice Direttore e Direttore di Produzione, Simone Piraino è autore di una notevole produzione e vanta, in qualità di compositore, numerose partecipazioni a Stagioni di Istituzioni e Festival internazionali e nazionali di prestigio.
In questo lavoro emerge il suo stile compositivo, come affermato dallo stesso compositore nelle brevi note da lui redatte in occasione di questa prima esecuzione:
“[Canto notturno] è un brano scritto con l’utilizzo di tecniche minimaliste, qui maggiormente legate alla struttura melodico-armonica che ritmica, ma, al contempo, una composizione che strizza l’occhio alle tecniche di scrittura della colonna sonora cinematografica.
La composizione è aperta dall’arpa sola che espone, già variato, il tema (canto notturno, appunto) su cui si fonda tutta la composizione e che emergerà, nella sua chiarezza, solo in chiusura del brano: poche battute per un canto dolce, caratterizzato dalla tecnica del ritardo, e da una sequenza accordale che sono il fondamento di tutta la composizione; segue l’esposizione degli archi con interessanti armonie cluster diatoniche e, successivamente, di fiati e percussioni, in un climax timbrico che chiude la prima sezione.
La seconda sezione inizia con un canone degli archi che, dal grave dei contrabbassi al registro dei primi violini, nasconde, man mano, il tema melodico già esposto precedentemente, esplicando il mistero notturno di un pensiero, una “domanda ultima”, che non viene mai meno ma, anzi, diventa sempre più forte. Il canone, con scambi di posizione, scontri e salti, è formato dalla scomposizione melodica del tema già esposto dall’arpa: nasce tutto da un seme”.
Proprio in questo aspetto consiste il senso del minimalismo di Piraino che trova i suoi aspetti maggiormente qualificanti nell’attenzione al piccolo particolare, nella sua valorizzazione, per qualcosa che, in germe, è già creata con l’Infinito come orizzonte. Si tratta di una forma di minimalismo sacro, più negli intenti che nel genere specifico del brano, che ricorda, da un lato, lo stile di compositori come Max Richter o Johann Johansson, e, dall’altro, quello di Arvo Pärt e di Henryk Gorecki, fautori proprio del mininimalismo sacro e suoi principali ispiratori. Nella descrizione del suo lavoro il compositore prosegue ancora:
“Come in un gioco di incastri, il canone passa ai legni mentre i corni, dapprima, e gli archi successivamente, riespongono il tema iniziale. L’ingresso del glockenspiel accompagnato dagli archi, suggerisce una pacifica nenia notturna (ispirata dalla nascita di mia figlia); seguono veloci terzine dell’arpa che ripensano il tema centrale, accompagnate dagli archi divisi in due sezioni (viole, celli e bassi nel registro grave e violini nel registro acuto), dal sapore cinematografico, linguaggio già affrontato da me in svariati lavori per il grande schermo. Il secondo climax, ovvero il riemergere delle domande ultime, con l’ingresso di fiati e percussioni, chiude il cerchio e porta, infine, a svelare il fondamento del canto notturno: anticipata dagli archi morenti, l’arpa chiude, sola, esponendo, per un’unica volta in tutto il brano, il tema su cui si fonda la composizione”.
Durata: 14'
Fryderyk Chopin
Żelazowa Wola, 1810 - Parigi, 1849Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21
Maestoso
Larghetto
Finale, Allegro vivace
Composti tra il 1829 e 1830, i due concerti per pianoforte e orchestra di Fryderyc Chopin sono due opere giovanili influenzate dalla cultura musicale, per certi aspetti, un po’ provinciale che si respirava a Varsavia in quegli anni. Chopin, ancora diciannovenne, viveva ai margini delle grandi e importanti trasformazioni che stavano coinvolgendo la musica e, quindi, la sua conoscenza della produzione concertistica era alquanto limitata. Come tutti i compositori, anche Chopin ebbe i suoi modelli di riferimento che a Varsavia, città solo sfiorata dalle grandi correnti culturali e musicali dell’epoca, erano rappresentati dalle opere di Hummel, Field, Steibelt e Gyrowetz, un compositore boemo, che, nei suoi lavori, non era rimasto estraneo a una certa influenza haydniana. Con evidente riferimento a questi modelli nacquero i due Concerti per pianoforte e orchestra di Chopin nei quali è presente lo stile Biedermeier, nome attribuito a un personaggio immaginario uscito dalla penna di Adolf Kussmaul e Ludwig Eichrodt, con il quale s’identificò un’intera epoca i cui limiti temporali sono rappresentati indicativamente dal 1815, anno in cui si celebrò la fine degli ideali rivoluzionari, e dal 1830, anno che vide l’affermazione della società borghese. In musica con questo termine vennero identificati tutti quei compositori, come Dussek, Cramer, Hummel, Field, Czerny e Ries, che in questo periodo cercarono tenacemente il successo, riuscendo a ottenerlo grazie alle loro doti virtuosistiche. Lo stile Biedermeir trovò la sua realizzazione in questi due concerti, in particolar modo, nel trattamento della parte orchestrale, la cui funzione è limitata all’accompagnamento del solista, nel carattere militaresco del primo movimento del Primo concerto e nella scelta di concludere il lavoro con melodie tratte dal repertorio popolare.
Questi due concerti hanno avuto una vicenda editoriale piuttosto particolare, in quanto l’ordine di pubblicazione è invertito rispetto a quello di composizione. Il Concerto n. 1 in mi minore per pianoforte e orchestra op. 11 fu, infatti, composto tra l’inverno e la primavera del 1830, cioè l’anno successivo a quello della stesura del secondo e catalogato con un numero d’opera inferiore, in quanto, secondo una prassi consolidata nell’Ottocento, la numerazione dell’opera era determinata dalla data di pubblicazione e non da quella di composizione. I caratteri peculiari dello stile Biedermeier si riflettono nel Concerto n. 2 in fa minore op. 21, composto tra il 1829 e l’inizio del 1830 ed eseguito per la prima volta in privato il 3 marzo 1830 e in pubblico a Varsavia il 17 marzo dello stesso anno. Questo Concerto, nonostante sia stato il più amato da Chopin, che lo eseguì con maggiore frequenza rispetto all’altro, nell’Ottocento non godette della stessa fortuna in quanto esso fu ripreso raramente da altri pianisti, tra i quali, però, spicca il nome illustre di Clara Schumann che mostrò di preferirlo negli ultimi anni della sua fulgida e brillante carriera. Dedicato a Delphine Potocka, bellissima contessa, con la quale si riteneva che Chopin abbia intrattenuto una relazione testimoniata da alcune lettere rivelatesi, poi, inattendibili, il Concerto fu invece ispirato da un altro amore del compositore per un’allieva di canto del Conservatorio di Varsavia, Konstancja Gladkowoska. Questo amore, che rimase solo platonico, è testimoniato da una lettera del 3 ottobre 1829 indirizzata al suo amico Titus Woychiechovski dove si legge: “Forse, per mia fortuna, ho trovato il mio ideale, a cui sono rimasto fedele, sebbene senza dire a lei una parola, per sei mesi; quella che sogno ed a cui è dedicato l’adagio del mio Concerto”.
Il primo movimento (Maestoso) si apre con un’introduzione orchestrale in cui vengono enunciati tutti gli elementi tematici che ne sono alla base. Il primo tema, apparentemente marziale per l’utilizzo dei ritmi puntati, presenta un carattere fortemente espressivo nella dolcezza della melodia che contraddistingue anche il secondo, affidato alle delicate sonorità dei legni. Dopo l’esposizione orchestrale il pianoforte fa il suo ingresso con un passo di carattere improvvisativo e diventa assoluto protagonista lasciando all’orchestra solo la funzione di accompagnamento, secondo i canoni dello stile Biedermeier. Il secondo movimento, Larghetto, e non Adagio, come è stato chiamato nella lettera citata in precedenza, presenta un accentuato lirismo che non esprime soltanto l’amore tutto romantico di Chopin per Konstancja, ma riflette anche lo stile Biedermeier per la sua scrittura di ascendenza operistica. Di particolare suggestione è la parte centrale nella quale il pianoforte si esibisce su veloci gruppi irregolari. Come nel primo, anche nel secondo Concerto l’ultimo movimento attinge il suo materiale musicale dal repertorio popolare, rappresentato, in questo caso, da una mazurca di straordinaria leggerezza.
Durata: 28'
Ludwig van Beethoven
Bonn, 1770 - Vienna, 1827Sinfonia n° 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”
Allegro ma non troppo
Andante molto mosso
Allegro
Allegro
Allegretto
La Sesta sinfonia di Beethoven, meglio conosciuta come Sinfonia “Pastorale”, fu concepita probabilmente nel 1802, anno in cui era stato eseguito, per la prima volta, l’oratorio di Haydn, Le Stagioni, nel quale erano descritti paesaggi naturali e la vita campestre. Beethoven, amante della natura, non si lasciò sfuggire l’occasione di comporre un lavoro a sfondo pastorale, ma alla forma dell’Oratorio preferì quella sinfonica per non subire imposizioni da un testo letterario. In questa sinfonia, tuttavia, Beethoven non si limitò a una semplice descrizione della natura, ma si propose lo scopo, come egli stesso scrisse, di far sì che essa, grazie alla magia degli strumenti musicali, manifestasse solo sentimenti. Egli stesso annotò, inoltre, che l’ascoltatore doveva essere capace di scoprire da sé le varie situazioni e formarsi un ideale di vita campestre senza bisogno di ricorrere a titoli per risalire con l’immaginazione alle intenzioni del compositore. La sinfonia, dedicata al principe Lobkowitz e al conte Rasumovsky, fu iniziata nell’estate del 1807 e, terminata nel maggio del 1808, fu eseguita per la prima volta, sotto la sua direzione, insieme alla Quinta e ad altri lavori in un lunghissimo concerto tenuto a Vienna, al Theater an der Wien, il 22 dicembre 1808. L’accoglienza del pubblico fu piuttosto fredda anche per la lunga durata dell’Accademia che comprendeva oltre alle due sinfonie, una Scena e aria, cantata da Mademoiselle Killishky, un Gloria, il Concerto n. 4 op. 58 per pianoforte e orchestra, un Sanctus con solista e coro e la Fantasia op. 80 per coro, pianoforte e orchestra. A tale proposito è significativo quanto scrisse il compositore Johann Friedrich Reichardt che, ospite del principe Lobkowitz, assistette al concerto: “Vi siamo stati a sedere dalle sei e mezza fino alle dieci e mezza in un freddo polare, e abbiamo imparato che ci si può stufare anche delle cose belle. Il povero Beethoven, che da questo concerto poteva ricavare il primo e unico guadagno di tutta l’annata, aveva avuto difficoltà e contrasti nell’organizzarlo. […] Cantanti e orchestra erano formati da parti molto eterogenee. Non era stato nemmeno possibile ottenere una prova generale di tutti i pezzi, pieni di passi difficilissimi. Ti stupirai di tutto quel che questo fecondissimo genio e instancabile lavoratore ha fatto durante queste quattro ore. Prima una Sinfonia Pastorale o ricordi della vita campestre pieni di vivacissime pitture e di immagini. Questa Sinfonia Pastorale dura assai di più di quanto non duri da noi a Berlino un intero concerto di corte. […] Poi, come sesto pezzo, una lunga scena italiana […] Settimo pezzo: un Gloria, la cui esecuzione è stata purtroppo completamente mancata. Ottavo brano: un nuovo concerto per pianoforte e orchestra di straordinaria difficoltà […]. Nono pezzo: una Sinfonia [la Sinfonia n. 5 op. 67]. Decimo pezzo: un Sanctus […]. Ma al concerto mancava ancora il “gran finale”: la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra. Stanchi e assiderati, gli esecutori si smarrirono del tutto”.
Lo stesso Beethoven evidenziò le difficoltà incontrate per l’esecuzione del suo concerto, ma scrisse anche che il pubblico lo aveva gradito. Leggiamo, infatti, in una lettera del 7 gennaio 1809: “Ci sarà forse qualche articolo offensivo nella Musikalische Zeitung (Gazzetta musicale) a proposito del mio ultimo concerto. Io non pretendo che si sopprima tutto quello che si dice e fa contro di me, ma occorre sapere che qui nessuno ha più nemici di me; e lo si capisce tanto meglio quando si vede quanto vada peggiorando lo stato della musica. Abbiamo direttori che ne capiscono di direzione tanto quanto ne capiscono di educazione – e al Theater an der Wien c’è veramente di peggio – è lì che ho dovuto dare il mio concerto e mi hanno piazzato ostacoli da tutte le parti. Mi hanno giocato un orribile scherzo, per puro odio nei miei confronti, perché il signor Salieri ha minacciato di espulsione tutti i musicisti della sua compagnia che avessero suonato per me; eppure, malgrado alcuni gravi errori che non potevo prevenire, il pubblico ha accolto tutto con il più grande entusiasmo. Ciò nonostante, gli scribacchini non mancheranno di scrivere robaccia contro di me nella Musikalische Zeitung. Gli orchestrali erano particolarmente furiosi perché soltanto per incuria sono stati commessi errori proprio nel pezzo più semplice e facile. D’un tratto io ho ordinato loro di fermarsi e ho gridato: “ricominciamo”. Una cosa del genere lì non era mai accaduta prima. Il pubblico ha testimoniato tutto il suo compiacimento”.
La Sinfonia “Pastorale”, innovativa rispetto al periodo in cui fu composta, è costituita, a livello macroformale, da cinque movimenti piuttosto che dai quattro tipici dell’era classica e a ciascuno di essi è stato attribuito da Beethoven un titolo programmatico. Nell’ordine i titoli sono: Risveglio di piacevoli sentimenti all’arrivo in campagna; Scena al ruscello; Allegra riunione di gente di campagna; Tempesta; Canzoni di pastori e sentimenti piacevoli e di ringraziamento dopo la tempesta. La natura sembra, quindi, protagonista dell’opera, ma solo nel modo in cui può essere vista e sentita dall’uomo e, come tale, per la sua capacità di suscitare sentimenti benevoli e sereni.
Il primo movimento, Allegro ma non troppo, si presenta calmo e piacevole nella descrizione dei sentimenti provati all’arrivo in campagna. Esso, in forma-sonata, è costituito da sette distinti motivi sviluppati in modo estensivo che conferiscono, con la loro ripetizione, una microscopica tessitura come non ha mancato di notare Yvonne Frindle, forse eccessivamente suggestionata dal titolo programmatico, scrivendo: “La ripetizione infinita del modello in natura è resa attraverso cellule ritmiche, la sua immensità attraverso pure armonie sostenute”.
Il secondo movimento, Andante molto mosso, anch’esso in forma-sonata e nella tonalità di si bemolle, si distingue per la serenità arcadica che sembra liberare l’uomo da tutti i problemi quotidiani. Esso inizia con un motivo che, affidato agli archi, rende chiaramente lo scorrere dell’acqua, imitato da due violoncelli alle cui note, suonate in sordina, rispondono il resto dei violoncelli e i contrabbassi con note in pizzicato. Verso la fine, tre legni imitano i richiami degli uccelli; lo stesso Beethoven, nella partitura, affidò la rappresentazione del canto degli uccelli a tre strumenti e precisamente l’usignolo al flauto, la quaglia all’oboe e il cucù al clarinetto.
Il terzo movimento in fa maggiore, in cui sono descritti i divertimenti di un allegro gruppo di contadini, si presenta nella forma di uno scherzo alterato. Vi sono, infatti, due trii in tempo binario interrotti alla loro apparizione da un passaggio esuberante in tempo 2/4. Nel Finale ritorna lo scherzo che riporta la calma con un tempo più lento dopo la sfrenata danza dei contadini i quali si accorgono che cominciano a cadere gocce di pioggia.
Il quarto movimento, Allegro, in fa maggiore, dipinge con accurato realismo un temporale i cui elementi sono descritti con scale cromatiche che evidenziano il passaggio dalle poche gocce di pioggia alla violenta tempesta con tuoni, fulmini e forti venti per arrivare, nel finale, ad una transizione di grande fascino che sembra esprimere la cessazione della tempesta e l’apparizione dell’arcobaleno. Non avendo una cadenza finale, molti critici hanno considerato questo movimento come un’introduzione al quinto, Allegretto, in fa maggiore e in forma di rondò-sonata. Qui il descrittivismo lascia il posto a sentimenti di serenità e quasi a una preghiera di ringraziamento a Dio, rappresentata da un tema di otto misure che, come nella maggior parte dei finali delle sinfonie, viene enfatizzato. L’opera si conclude con una coda che, secondo Antony Hopkins, presenta la musica più bella della sinfonia. Particolarmente suggestiva è, infatti, in questa parte conclusiva, la ripresa del tema in pianissimo e sottovoce, enfatizzata rallentando leggermente il tempo.
Riccardo Viagrande
Durata: 40'