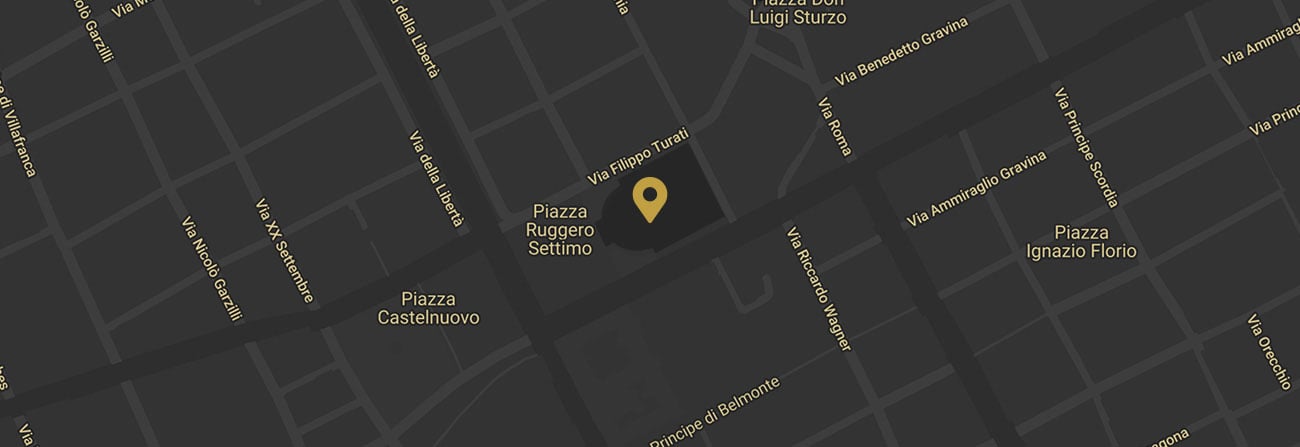Marco Angius /Clementi / Schumann
Marco Angius. direttore
Giuseppe Albanese, pianoforte
-
Programma
-
Franz Schubert
Vienna, 1797 - Vienna, 1828 Aldo Clementi
Catania 1925 - Roma 2011Vier Ländler (Quattro danze) D. 814. Trascrizione per orchestra di Aldo Clementi
Anno di composizione: 1824. Il 7 maggio dello stesso veniva eseguita per la prima volta a Vienna la Nona sinfonia di Beethoven, mentre in Italia Giacomo Leopardi pubblicava le Operette morali.
“Mi sento legato ai grandi musicisti del passato, a Schubert, a Schumann, a Chopin e a tutti i romantici”.
Come affermato dallo stesso Aldo Clementi, Schubert costituì, dunque, una delle fonti d’ispirazione del compositore italiano che, nel suo Secondo concerto per violino e strumenti, composto nel 2006, utilizzò un frammento di Schubert, manipolandolo ed elaborandolo, allo scopo di ottenere un contrappunto da affidare al solista e all’orchestra. In effetti la poetica che informa la produzione più matura di Aldo Clementi si basa sulla constatazione secondo la quale “la musica di oggi è così frammentaria che è difficile ritrovare un filo. A partire dagli anni Sessanta e Settanta si è perso il carattere esplosivo di certe invenzioni: non c’è più un Boulez, uno Stockhausen, un Cage. D’altra parte oggi i musicisti sono diversi perché l’epoca è diversa”.
Appare, dunque, conseguenziale da parte del compositore un ritorno al passato, in quanto, come da lui affermato: “i musicisti che hai imparato a scuola ti restano dentro, compaiono in un modo o nell’altro nella tua musica. Io vedo l’impronta della musica precedente in una gran parte di ciò che sento, anche se poi è difficile differenziare che cosa sia di questo o di quello, soppesando i componenti con il bilancino da farmacista”.
Un ritorno al passato è anche quest’orchestrazione delle Vier Ländler D. 814 per pianoforte a quattro mani, composte da Franz Schubert nell’estate del 1824, ma pubblicate postume, come una buona parte della sua produzione, nel 1869. Clementi ha dato una nuova veste orchestrale a questi lavori, che, appartenenti al filone della cosiddetta «musica d’uso», tanto in voga nella Vienna della prima metà dell’Ottocento, si distinguono per una tenera cantabilità melodica che solo nel terzo brano cede il posto a una maggiore incisività ritmica.
Durata: 10'
Robert Schumann
Zwickau, 1810 - Bonn, 1856Concerto in la minore op. 54 per pianoforte e orchestra
Allegro affettuoso
Intermezzo
Allegro vivace
Periodo di composizione: I Movimento (Lipsia, 20 maggio – giugno 1841); II e III movimento (1845).
Prima esecuzione: Dresda, 4 dicembre 1845. L’anno successivo, il 21 febbraio 1846 scoppia a Cracovia una rivolta guidata da Edward Dembowski per l’indipendenza della Polonia dall’Austria mentre a Roma, il 1° giugno 1846, muore papa Gregorio XVI.
“Il mio Concerto è un compromesso fra una Sinfonia, un Concerto, e una vasta Sonata. Mi accorgo che non posso scrivere un Concerto per i virtuosi – debbo progettare qualcos’altro”.
È questo il primo accenno, contenuto in una lettera indirizzata da Schumann nel 1839 alla futura moglie Clara, al progetto di comporre un concerto per pianoforte e orchestra. Tale progetto rimase, però, nel cassetto per un certo periodo di tempo e soltanto qualche anno dopo fu completamente realizzato. Il matrimonio con Clara, nel 1840, aveva regalato a Schumann momenti felici e la necessaria serenità per comporre. Risale a questo periodo, infatti, la composizione di una Fantasia per pianoforte e orchestra che fu eseguita il 13 agosto 1841 al Gewandhaus di Lipsia con la moglie al pianoforte. Nonostante il successo tributatole dal pubblico, la Fantasia non fu molto apprezzata dagli editori che si rifiutarono di pubblicarla. Schumann, ormai senza più speranza di trovare un editore disposto a investire su questa composizione, decise di utilizzarla come primo movimento di un concerto aggiungendo un Intermezzo e un Finale. Il Concerto, tanto atteso da Clara che aveva manifestato la sua gioia in una pagina del suo diario (Ora il lavoro è diventato un Concerto, che penso di suonare durante il prossimo inverno. Sono molto felice di questa novità, giacché ho sempre sperato da lui un grande pezzo di bravura), fu completato nel mese di luglio del 1845, come si apprende da un’altra annotazione del 31 dello stesso mese:
“Robert ha ultimato il Concerto e lo ha inviato al copista. Quanto a me, mi sento felice come un re al pensiero di suonarlo con l’orchestra”.
Il desiderio di Clara, che iniziò a studiarlo mercoledì 3 settembre con grande entusiasmo per la ricchezza dell’invenzione e la freschezza delle idee, si realizzò presto e il Concerto fu da lei eseguito in qualità di solista il 4 dicembre 1845 all’Hôtel du Saxe a Dresda sotto la direzione di Ferdinand Hiller. In quell’occasione i tre movimenti vennero indicati nel programma come Allegro affettuoso, Andantino e Rondò, con quest’ultimi legati insieme in modo da formare un unico blocco. Circa un mese dopo, il primo gennaio del 1846, il Concerto fu eseguito al Gewandhaus di Lipsia sempre con Clara al pianoforte e Mendelssohn sul podio.
Nonostante la volontà di Schumann di dare una certa unità formale a questo concerto, in realtà il risultato finale non fu conforme alle sue intenzioni, dal momento che il legame, sulla scia di Mendelssohn, tra il secondo e il terzo movimento ottenuto con una citazione del tema principale, ripreso in una forma rielaborata, appare come un puro espediente formale incapace di conferire al brano quella solida e profonda unità sperata. Il tema principale, che, nel primo movimento, originariamente costituiva la suddetta Fantasia, nelle prime tre note richiama il nome della moglie, detta Chiarina, dal momento che il do, il si e il la vengono chiamati, nei paesi anglosassoni, C, H, in quanto si naturale, e A. Di grande effetto è l’attacco del primo movimento, Allegro affettuoso, con una cascata di accordi del pianoforte che introduce l’esposizione nella quale s’integra e dialoga in forma paritetica con l’orchestra, mentre il secondo movimento, Intermezzo (Andantino grazioso), presenta una struttura tripartita secondo lo schema A-B-A1. Il tema principale è tratto dal disegno ascendente della seconda parte del secondo inciso di quello del primo movimento e contrasta con quello della seconda sezione esposto dal violoncello. Anche il Finale, Allegro vivace, la cui struttura formale si richiama alla forma-sonata, si basa sul tema principale del primo movimento.
Durata: 37'
Sinfonia n. 1 (“La Primavera”) in si bemolle maggiore op. 38
Andante un poco maestoso, Allegro molto vivace
Larghetto
Scherzo: molto vivace
Allegro animato e grazioso
Periodo di composizione: Lipsia, 20 gennaio – 20 febbraio 1841
Prima esecuzione: Lipsia, Gewandhaus Saal, 31 marzo 1841. Tra gli eventi storici degli anni ’40 dell’Ottocento vanno ricordati: la prima rappresentazione, il 9 marzo del 1842, del Nabucco di Giuseppe Verdi; pubblicazione del 1842 de I promessi sposi di Alessandro Manzoni e nel 1848 del Manifesto del Partito Comunista da parte di Karl Marx e di Friedrich Engels.
“Ho la tentazione di distruggere il mio pianoforte: è diventato troppo angusto per contenere le mie idee. Ho davvero ben poca esperienza in fatto di musica orchestrale, ma non dispero di poterne acquisire…”
Con queste parole Robert Schumann espresse la sua volontà di cimentarsi in nuovi modi espressivi più rispondenti alla maturità stilistica che sentiva di aver raggiunto, incoraggiato anche dalla moglie Clara che da tempo aveva notato l’evoluzione estetica del marito. Così Schumann, dopo aver innalzato a opera d’arte il Lied, decise, sulla scia di Beethoven, di Schubert e di Mendelssohn, di ritornare al genere sinfonico dopo nove anni dall’esecuzione, avvenuta nel 1832 a Zwickau, di un suo brano per orchestra da lui successivamente rinnegato. Il desiderio spasmodico di scrivere qualcosa che non fosse per il pianoforte lo prese a tal punto che in soli quattro giorni, dal 23 al 26 gennaio 1841, egli riuscì già ad abbozzare la sinfonia che finì di orchestrare entro il 20 febbraio, come apprendiamo da quanto scrisse nel suo diario il 14 febbraio:
“La sinfonia mi ha dato molte ore felici, è quasi terminata. Spesso ringrazio lo Spirito benefico che mi ha permesso di portare così facilmente a termine, in così poco tempo, un’opera di questa importanza: l’abbozzo dell’intera sinfonia è stato completato in quattro giorni. Dopo numerose notti di insonnia viene l’esaurimento”.
La sinfonia, intitolata anche Primavera, fu eseguita per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia il 31 marzo 1841 sotto la direzione di Felix Mendelssohn. Secondo quanto scritto nel suo diario dalla moglie, egli diede alla sinfonia il titolo di Primavera perché si era ispirato a un poema di Adolph Böttinger dedicato alla primavera, mentre il marito aveva dato una spiegazione diversa dicendo più semplicemente di essersi ispirato al suo Liebesfrühling (Spirito di amore).
La Sinfonia n. 1 è divisa in quattro movimenti intitolati: Frühlingserwachen (Risveglio della primavera), Abend (La sera), Frohe Gespielen (Compagni giocosi), Voller Frühling (La piena primavera). Il primo movimento si apre con un Andante poco maestoso introduttivo il cui tema di carattere solenne, che informa l’intera composizione, è affidato inizialmente ai corni e alle trombe, ai quali risponde tutta l’orchestra. Segue una nuova melodia affidata ai flauti, agli oboi e ai clarinetti e, in seguito, sviluppata dall’orchestra. Dopo un dialogo intrecciato dalle viole e dai violini secondi, che prosegue, poi, tra violini primi e secondi, un grande crescendo porta all’Allegro molto vivace in forma-sonata con un primo tema che riprende e sviluppa quello iniziale, al quale si contrappone un secondo di carattere cantabile affidato ai clarinetti e ai fagotti. La struttura dialettica tipica del bitematismo della forma-sonata viene, però, contraddetta sia a livello microformale dall’introduzione nella sezione di sviluppo di questo primo movimento di un terzo tema basato su una scala ascendente affidata ai clarinetti e ai fagotti, sia a livello macroformale da una struttura ciclica che collega i vari movimenti attraverso idee tematiche che anticipano quelle dei tempi successivi. Un esempio di questo modo di procedere ci è fornito dal successivo Larghetto, in cui ai due temi principali, dei quali il primo, cantabile, è affidato ai primi violini, mentre il secondo agli oboi e ai secondi violini, fa seguito una breve coda con un tema inatteso e quasi in contraddizione con il resto del brano che serve, tuttavia, a Schumann per introdurre il successivo Scherzo. Lo Scherzo presenta una struttura formale alquanto complessa riassumibile nello schema A-B-C-A-B-D con le lettere C e D che rappresentano i due Trii introdotti da Schumann in questo movimento di straordinaria intensità ritmica. Il quarto movimento, Allegro animato e grazioso, pur essendo strutturato secondo i canoni della forma-sonata con un’esposizione bitematica, con uno sviluppo e con una ripresa, è un’ulteriore conferma della concezione ciclica di questa sinfonia con il ritorno, da parte dei tromboni, nella sezione di sviluppo al tema iniziale della sinfonia.
Riccardo Viagrande
Durata: 33'